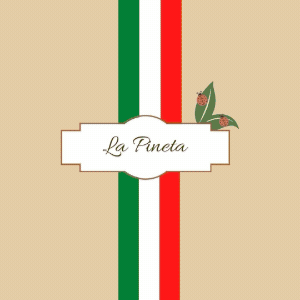di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte web)
Una distesa di fiocchi di neve, in una notte d’estate, che biancheggia a mezz’aria fra le lampade emanando una fragranza dolce e inebriante in un paesaggio sospeso e incantato. Ecco come nel 1975 appariva una coltura di gelsomini di prima mattina. E’ una storia lunga e appassionante quella della coltivazione del gelsomino in Calabria. La Costa dei Gelsomini (o Riviera dei Gelsomini) è il nome con cui, ancora oggi, si identifica la zona costiera di Reggio Calabria bagnata dal mar Ionio, proprio perché dal 1920 al 1970 molti ettari di terreno erano impegnati nella coltivazione del gelsomino che, insieme al bergamotto, costituì, quasi nello stesso periodo, il prodotto di eccellenza dell’intera zona. Pare che il gelsomino fu coltivato a scopi industriali per la prima volta sul finire degli anni Venti, in un terreno situato nel litorale ionico calabrese, tra Brancaleone e Ferruzzano.
Le piantagioni, in seguito, si moltiplicarono per le favorevoli condizioni climatiche della zona fino ad estendersi da Villa San Giovanni a Reggio proseguendo per tutta la costa ionica fino a Monasterace. Le essenze, che si ricavavano dai fiori di gelsomino, trova¬rono larghissima applicazione nel settore dell’industria profumiera e cosmetica soprattutto francese e la forte richiesta di tutto il mercato internazionale si indirizzò verso la Calabria favorendo la nascita di numerose imprese dedite a questa coltura divenuta in poco tempo identificativa di questa parte di territorio calabrese.
Nel 1932 la Stazione sperimentale delle essenze di Reggio Calabria in¬stallò a Brancaleone un impianto di estrazione dell’essenza proprio per far conoscere questa tecnica di lavorazione. In seguito a questa iniziativa, che riscosse molto successo tra i coltivatori, sorsero nuovi stabilimenti di estrazione nei diversi centri, tantochè circa il 99% dei fiori coltivati in Calabria veniva trasformato dagli stes¬si latifondisti. Esistevano impianti industriali a Reggio (di Vilardi, Giuffrè), a Villa San Giovanni (di Lucisano), a Saline Joniche (di Meduri), a Melito Porto Salvo (di Sergi), a Brancaleone (di Correale), a Bovalino (di Meduri), a Locri (di Ocello), a Gioiosa Jonica (di Zamparelli) e a Roccella (di Cappelleri). Il lavoro della raccolta era precario, limitato alla stagione estiva, eseguito di notte e spesso a piedi nudi nel terreno irrigato, ogni sera antecedente, a causa delle alte temperature stagionali.
La raccolta esigeva un’estrema destrezza dei gesti per evitare che i fiori si sciupassero e, per questa peculiare necessità, la mano d’opera era costituita quasi per la totalità da donne, denominate gelsominaie. Esse si alzavano in piena notte e, in gruppi di venti o trenta, si recavano a piedi fino ai campi per iniziare la raccolta quando era ancora buio o alle prime luci dell’alba evitando così che già i primi raggi del sole rovinassero i delicatissimi fiori. Le gelsominaie riempivano di fiori i loro grembiuli e man mano li svuotavano in ceste di canna o vimini che poi, a fine raccolto, portavano alla pesatura. Nelle otto ore di lavoro (in genere si terminava entro le nove del mattino) le lavoratrici, costrette a portare con sé i figli più piccoli, li adagiavano nei magazzini in cui si sarebbe svolta al mattino la pesa dei fiori, mentre i figli più grandicelli, in genere dai 6 ai 12 anni, partecipavano alla raccolta perché riuscivano con le loro piccole mani a staccare i fiori senza ammaccarli contribuendo così ad incrementare la quantità ottenuta dalle madri.

Le gelsominaie più abili ed esperte riuscivano, in un solo giorno, a raccogliere fino a circa 11-12 chili di fiori. Dalla distillazione di essi si ricavava l’essenza e da questa la “concreta”, una crema dura e concentrata profumatissima e preziosissima (per un chilo di concreta occorreva distillare dai 500 ai 600 kg di fiori) che era molto apprezzata dalle industrie profumiere francesi. Il lavoro delle raccoglitrici rappresentò, dagli anni Cinquanta fino a tutti gli anni Settanta del secolo scorso, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la formazione di un’intensa rete commerciale tra le imprese agricole del territorio ed i marchi dell’in¬dustria profumiera. Degna di menzione è la stagione delle battaglie sindacali promosse dalle raccoglitrici trovatesi, per effetto dell’emigrazione degli uomini, a dover sostenere la famiglia e quindi a combattere per ottenere i loro diritti, non solo retributivi. Alfine si giunse ad un miglioramento delle condizioni lavo¬rative nel «Contratto collettivo 13 agosto 1959 per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino della Provincia di Reggio Calabria» che comprendeva, fra gli altri vantaggi, il pagamento dell’indennità di caropane, di un’altra indennità per il viaggio fino ai campi e una paga settimanale di maggiore consistenza. Quando, intorno alla fine degli anni 70, le industrie profumiere francesi incominciarono a riprodurre sinteticamente alcune fragranze, tra cui il gelsomino, iniziò la crisi del settore che fu anche determinata, alfine, sia da un eccesso di produzione rispetto alla domanda sia dalla concorrenza di altri Paesi dell’area mediterranea (quali Egitto, Israele, Spagna, Algeria e Tunisia) forti sul mercato di un minor costo della manodopera. Si assistette quindi ad un crollo delle vendite dell’essenza di gelsomino che provocò, nel giro di un decennio, la sparizione della splendida col¬tura dalle coste calabresi. Una distesa di fiocchi di neve…. che biancheggia.
La raccolta dei gelsomini
Curva la schiena abbronzata a patteggiare co1 cespuglio/gravata dal grembiale di fiorellini gonfio/come nuvola di gocce racchiusa./Mani lordate da nere rughe che bivaccano tra i fuscelli/a rubare solo i fiori già schiusi./Grevi occhi dalla notte non ancora consunta/ con le lampade ondeggiano il buio bluastro. /Seguono le mani./Ormai non si levano più a mirare la distesa/ dalla strada fin la montagna a baciare/candida in ogni dove./Dolciastra brezza fantastica 1’olfatto/accentando nell’aura brulicante di braccia di Calabria /braccine di bimbe al lavoro./Con i fazzoletti saltellano gelsomini nei materni grembi/a rinfrancarne la raccolta/in transumanza a rituffare rosee mani tra i bruscoli /senza violare alcuno./Il sole accenna a1 confine opposto/là sul mare./La luce poi dal passo segnato al trotto/ raggrinza i boccioli smarriti/mentre si forma ciarlante la fila delle donne/per la pesa dei futuri profumi./Oggi al vagito della calda stella si è dissolta la scena, /domani a notte alta si replicherà. (Tratta dalla silloge “Opalescenti farfalle” di Maria e Patrizia Massara ed. Camer-Falzea).