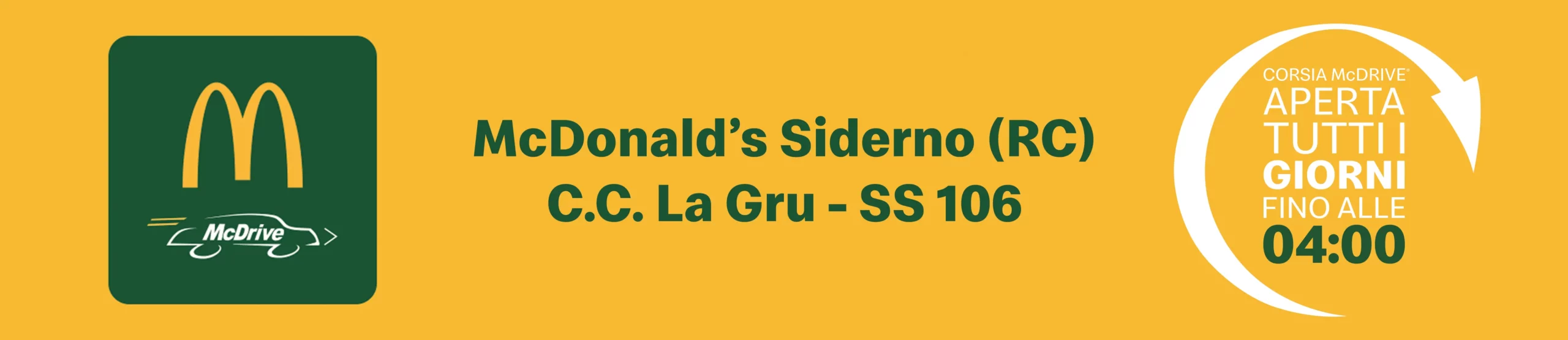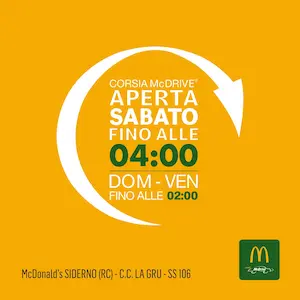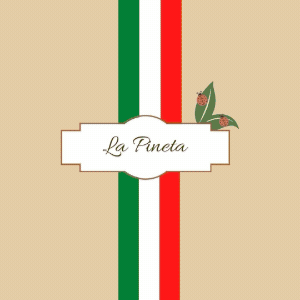(foto di repertorio)
*di Mario Staglianò
Di norma pensiamo al merito come a una cosa buona.
Un ideale a cui tendere, un’aspirazione.
E se l’alternativa è rappresentata da corruzione, nepotismo, relazioni famigliari, allora il principio del merito è ancora più affascinante.
E lo diventa ancora di più perché noi tutti vogliamo che le persone siano qualificate per il loro ruolo.
Se abbiamo bisogno di un chirurgo vogliamo che sia qualificato per quella professione quindi, in questo senso, il merito è una cosa buona.
Come può, allora, il merito diventare una tirannia?
Per capirlo dobbiamo fare qualche passo indietro e risalire alla vita sociale e politica di qualche decennio fa.
Negli ultimi quarant’anni, il divario tra perdenti e vincitori è diventato via via sempre più profondo, ha avvelenato la politica e creato sempre più divisioni.
Questo è accaduto, in parte, per le crescenti ineguaglianze portate dalla globalizzazione neoliberale ma non solo.
C’è stata anche un’evoluzione del nostro atteggiamento nei confronti del successo che ha accompagnato l’aumento delle ineguaglianze.
Le persone che hanno raggiunto l’apice della scala sociale sono convinte che il loro successo sia il risultato del loro operato e sono, quindi, certi di meritare i premi che la società riversa su di loro.
E l’implicazione tacita è che anche le persone rimaste indietro si meritano il loro destino.
Questo modo di pensare deriva da un principio apparentemente affascinante: se le opportunità sono le stesse per tutti, significa che i vincitori si sono meritati di vincere.
Ma la meritocrazia intesa in questo modo ha un lato oscuro.
I problemi sono due.
Uno è che spesso non siamo all’altezza dei principi meritocratici che professiamo ma la domanda filosofica principale è questa: anche ammesso che fossimo in grado di stabilire delle condizioni realmente paritarie per tutti, sarebbe una società giusta e buona quella che si verrebbe a creare?
Lo sarebbe fino a un certo punto e per diverse ragioni. La meritocrazia corrode il bene comune e la solidarietà.
Corrode il bene comune perché crea una società di vincitori e perdenti.
L’idea che i vincitori si siano guadagnati – e si meritino – il successo, genera una tracotanza meritocratica nei vincitori ed un senso di demoralizzazione e, persino, di umiliazione in chi non è riuscito a emergere.
I vincitori tendono a dimenticare la fortuna che li ha assistiti e a disprezzare chi non riesce a raggiungere il successo.
E’ per questo motivo che la meritocrazia crea una società di vincitori e di perdenti in cui l’élite meritocratica disprezza chi non è emerso e che è in difficoltà avverte il peso di questo disprezzo, covando un tipo di risentimento che induce ad abbracciare, per reazione contro le élite, una fede rancorosa di tipo populista.
Un possibile antidoto alla tracotanza meritocratica, un concetto etico di grande potenza, è che anche chi lavora strenuamente, con grande impegno, non deve credere che sia tutto esclusivamente il risultato dello sforzo messo in campo.
Perché nella vita sono tante le contingenze che determinano il successo, il raggiungimento di un risultato.
C’è la contingenza del talento ma avere un talento o l’altro non è frutto del nostro operato.
Per quanto io lo possa coltivare è, di fatto, un dono e non sono io ad averlo conquistato.
Inoltre il fatto che i miei talenti siano particolarmente apprezzati e valutati nella società in cui vivo, ancora una volta, non è opera mia bensì questione di fortuna.
Essere consapevoli delle coincidenze, delle contingenze che hanno reso possibile il nostro successo, può rappresentare un antidoto alla tracotanza meritocratica e indurre un sentimento di umiltà che fa capire che è per fortuna, o per grazia di Dio, o per il mistero del destino che io sono io.
Questa consapevolezza genera, inoltre, un senso di riconoscenza nei confronti delle comunità che hanno reso possibile il mio successo, nei confronti della famiglia, degli insegnanti, dell’epoca in cui viviamo.
Una tendenza a capire in cosa siamo debitori agli altri membri della nostra società, magari meno fortunati di noi.
In questo modo, una consapevolezza del ruolo della fortuna può aprirci alla possibilità di una maggiore solidarietà e senso di riconoscenza reciproca.
Il fascino del principio meritocratico consiste non solo nel fatto che premiare il successo costituisce un incentivo per lavorare ancora di più; questa, è una motivazione pratica, utilitaristica.
C’è un’altra idea, più profonda, che riguarda il merito ed è il pensiero seducente che noi possiamo essere liberi agenti, padroni del nostro destino.
Che siamo individui auto-sufficienti che esercitano la libertà come se ne fossero padroni.
E’ un’idea potentissima soprattutto in Occidente e, più ancora, negli Stati Uniti, dove il concetto stesso di “sogno americano” si riferisce alla capacità di emergere sulla base esclusiva del proprio lavoro e della propria determinazione.
L’unico modo per provare a contestarla e riconsiderarla, non è criticare il concetto di libertà e di intervento umano bensì dimostrare che l’idea di uomo auto-sufficiente, che si crea da sé, rispecchi una concezione errata di libertà.
Bisogna, invece, abbracciare e mettere in pratica una concezione diversa di libertà; non la libertà dell’individuo che basta a se stesso bensì un tipo di libertà civica.
Noi esercitiamo l’arbitrio umano quando viviamo in una società che ci consente di confrontarci con i nostri concittadini, fra pari, sul nostro destino collettivo.
Quando abbiamo una voce, un’opinione significativa sugli obiettivi che la società dovrebbe perseguire.
Questa è la libertà civica che si basa su una concezione di libertà che ci vede collocati, ingombri e indebitati.
Esseri umani che condividono la responsabilità della comunità per il bene comune.
Questa nozione di intervento umano e di libertà è connessa al dibattito collettivo sul bene comune e su scopi e obiettivi di noi.
L’unico modo di argomentare davvero contro una società neo liberale, meritocratica, guidata dal mercato, è trasformare il concetto di intervento umano, offrendo come alternativa una più ricca concezione civica di libertà.