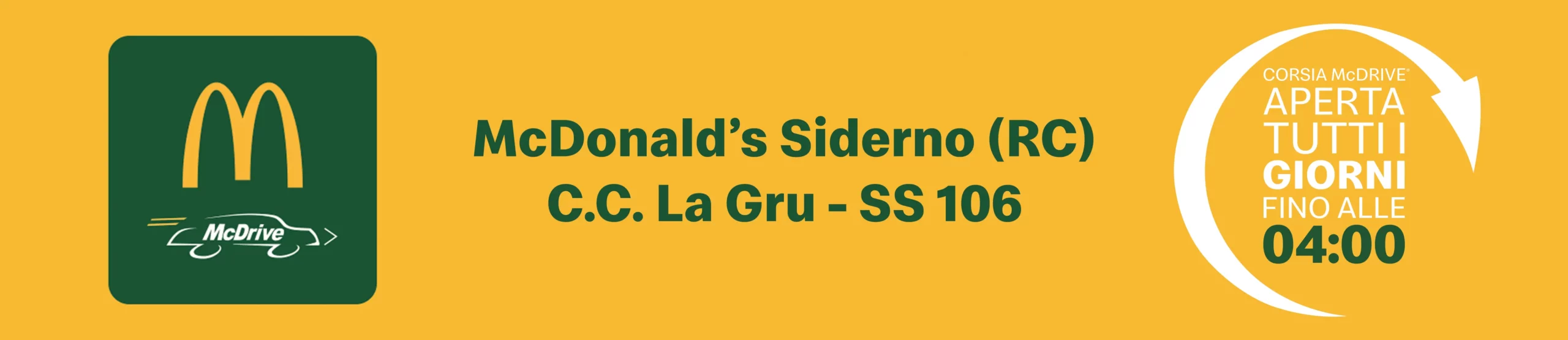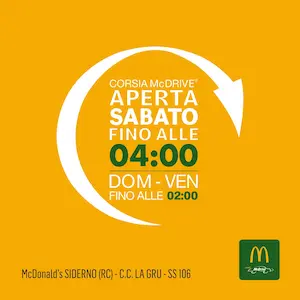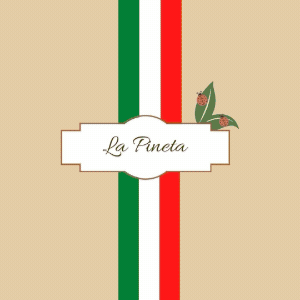di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Wikipedia)
Gerhard Rohlfs, (Berlino, 14 luglio 1892 – Tubinga, 12 settembre 1986), filologo, linguista e glottologo tedesco, soprannominato l'archeologo delle parole, fu anche un umanista di vasta cultura e ampi interessi. La fama di Rohlfs è legata soprattutto ai suoi viaggi indirizzati verso "le fonti delle lingue romanze" e ai suoi relativi studi. Avendo ereditato dall'Ottocento l’amore per l’esperienza dell' Italienische Reise (it.: Viaggio in Italia), si è dimostrato, nel suo approccio multiforme alla realtà italiana, il migliore erede di Goethe. Definito anche il “Patriarca dei linguisti” dal filologo italiano Alberto Varvaro, è stato una delle personalità scientifiche più significative del Novecento lasciando una produzione letteraria di oltre 700 titoli che riguarda soprattutto il vasto dominio delle lingue romanze, ma in particolare dell’italiano e, in modo speciale, i dialetti della Calabria. Docente di filologia romanza all'Università di Tubinga e all'Università di Monaco di Baviera, fu incaricato di condurre sui dialetti dell'Italia Meridionale un ampio studio da cui fu talmente coinvolto che la sua tesi di laurea, del 1924, ebbe proprio il titolo Griechen und Romanen in Unteritalien (Greci e Romani nella Bassa Italia). Arrivato in Calabria dopo esser stato preceduto da una lettera di presentazione di Benedetto Croce, tra il 1921 e il 1983 esplorò 365 paesi cogliendo la ricchezza peculiare della Calabria, a Nord intrisa della latinità diffusasi in larga parte dell’Europa ai tempi dell’impero Romano e a Sud pervasa dalla grecità ancora incontaminata, in cui la lingua appariva non intaccata e parlata come nell'antica Magna Grecia.
Il 1922 segna l’inizio di una lunga ed epica campagna di ricerche linguistiche nelle piazze, nelle osterie, nelle case, nelle campagne, con percorsi a dorso di mulo e disavventure varie. Amava dire che le ricerche dialettali si fanno coi piedi oltre che con la testa e l’etimologia deve essere studiata in stretta relazione con gli oggetti, i manufatti e i fenomeni culturali. Eccolo quindi in Calabria, ad assistere al parto di una giovenca, alla lavorazione del formaggio e della ginestra, alla vendemmia, all’antico gioco degli astragali (su cui pubblica un magistrale studio), in un instancabile pellegrinaggio, durato oltre 60 anni, per tutti i paesi più sperduti della regione, sempre armato di macchina fotografica e con montagne di schede raccolte in scatole per scarpe. In ogni paese Rohlfs aveva i suoi informatori e molti ricordano l’imbarazzo di fronte all’illustre professore straniero che alle scuse di molti “ma io non conosco il tedesco: possiamo parlare in italiano?” rispondeva amabilmente: “Megghju ‘n dialettu!”. Oltretutto parlava nel dialetto del posto con le sue tipiche varianti e giungeva persino a correggere gli interlocutori locali quando il loro dialetto risultava contaminato da altre parlate. Per esempio, mise in evidenza come persistevano nell’Aspromonte i termini denigratori parpàtulu, paddècu, zàmbaru, tamàrru e zangrèu, tutti appellativi che nei vari dialetti del reggino hanno più o meno lo stesso significato di zoticone, poveraccio, ignorante e scemo sottolineando che esse sono tutte voci grecaniche designanti i Greci dell’Aspromonte. Di tutti i viaggiatori stranieri autori di pedestrian tours in Calabria, egli fu certo il più impavido, costante e innamorato al punto da diventare più calabrese dei calabresi (ipsis Italis Italior lo definì il glottologo Giuliano Bonfante). Nel 1928 Rohlfs scriveva sulla rivista Anthropos: “Scompariranno irrevocabilmente anche questi ultimi avanzi del greco italico, se non interviene il Governo d’Italia. Esso non avrebbe anche l’alto compito di conservare e tutelare queste minoranze linguistiche, questi ultimi discendenti di una popolazione che a Roma diede una volta la sua cultura e la sua tradizione artistica? Forse quei paesi greci hanno meno diritto di essere dichiarati monumento nazionale che i trulli di Alberobello e le pitture bizantine?”. Il principale e indiscusso merito di Rohlfs, comunque, è aver attratto sulla Calabria l’attenzione degli studiosi di tutto il mondo. Essi non si sono potuti sottrarre alla sfida lanciata dalla sua tesi sulla continuità “extemporibus antiquis” peculiare della grecità contemporanea e che indicava nella Calabria la vitalità di una cultura illustre e antica ancora rilevabile nelle parole dei contadini e dei pastori. Inutile dire che la sua tesi riscosse per lo più consensi tra gli studiosi stranieri e quasi tutti dissensi tra quelli italiani. Rolhfs, infatti, diffuse le sue scoperte nell’Italia del periodo fascista e ben presto la polemica suscitata assunse l’aspetto di una querelle politica e ideologica. La cultura universitaria si era allineata alla politica del regime che non tollerava l’inquinamento dell’italiano, figlio della cultura latina, da parte della “malerba dialettale” e, ancor meno, accettava che uno studioso straniero mettesse in luce la superiorità del greco proprio quando era d’obbligo promuovere il programma imperiale in nome della romanità. Così una conferenza del Rohlfs, nell’aprile 1932 a Cosenza, sulle origini della grecità calabrese, fu sospesa a causa dell’ostilità degli intellettuali fascisti. Racconta Rohlfs in una lettera al suo biografo Salvatore Gemelli:“La conferenza era stata annunciata con manifestini affissi nelle strade principali della città. Sapevo che la mia teoria non piaceva all’Italia fascista; perciò quella conferenza sembrava una vera offesa alla Nazione italiana che stava conquistando l’Abissinia. Come si faceva a pensare, allora, ad un’Italia che non avrebbe avuto la forza di distruggere la grecità in casa propria? Per ordine del federale, la conferenza fu impedita con un annunzio applicato sugli stessi manifestini, motivandolo con la mia cattiva salute. A tale interdizione gli risposi con una lunga passeggiata, che feci nelle ore serali (ora della conferenza) per il corso principale della città”. Ma la risposta più eloquente del professore tedesco fu il miglior vocabolario regionale che vanti la dialettologia italiana, il Dizionario dialettale delle Tre Calabrie che cominciò a uscire a fascicoli a Halle in Sassonia (1932-1936), seguito dalla summa delle sue teorie Scavi linguistici nella Magna Grecia (1933). Sempre nel 1932 pubblicò per la prima volta il Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria. Pubblicò, in seguito, due vocabolari completi del dialetto calabrese (Milano, 1938-1939) e si occupò estesamente della lingua greco-calabra e greco-salentina, sostenendo la tesi che tali dialetti greco-italioti fossero frutto dell’ellenizzazione magnogreca. Si contrappose così alla teoria di Giuseppe Morosi che ne affermava, invece, la derivazione bizantina sulla scia dell’emigrazione greca dei secoli IX–XVI in Calabria.Nel 1944 la Gestapo sospese dall’insegnamento Rohlfs per alto tradimento, ma i suoi studi continuarono. Nel Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, pubblicato per la seconda volta nel 1977 da Longo, a Ravenna, è da evidenziare la dedica da lui apposta: “a voi / fieri calabresi / che accoglieste ospitali me straniero / nelle ricerche e indagini / infaticabilmente cooperando/alla raccolta di questi materiali/ dedico questo libro / che chiude nelle pagine / il tesoro di vita / del vostro nobile linguaggio”. Sempre nel 1977, all’Accademia dei Lincei, in occasione di una sua conferenza dal titolo L’antico ellenismo nell’Italia di oggi (sostrati e riflessi) parlò della vexata quaestio, che ancora divideva gli studiosi, sull’antichità delle parlate grecanichedell’Aspromonte e del Salento apportandonuovi elementi a sostegno della sua “tesi della continuità”. I suoi viaggi in Calabria, dopo la Liberazione, ripresero con maggior frequenza fino alla vigilia della morte. Rohlfs ha ricevuto la cittadinanza onoraria dei comuni di Bova (1966), Candidoni (1979), Tropea e Cosenza(1981) e, il 13 aprile 1981, gli è stata conferita dall’Università della Calabria la laurea honoris causa in Lettere. Il 21 maggio 2016 è stato inaugurato, sempre a Bova, il Museo della Lingua Greco-Calabra, intitolato proprio al glottologo tedesco.
(Brani da “Gerhard Rohlfs: la Calabria contadina: scavo linguistico e fotografie del primo Novecento” di Gerhard Rohlfs a cura di Antonio Panzarella, Edizioni Scientifiche Calabresi).