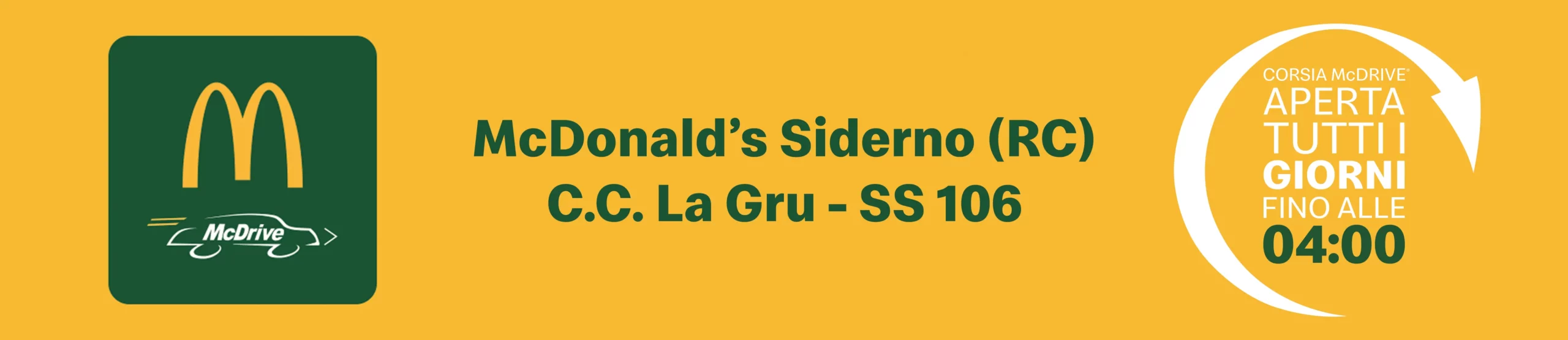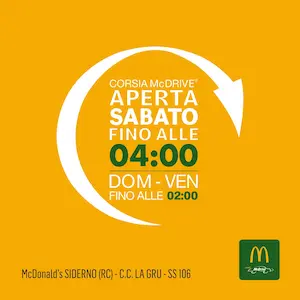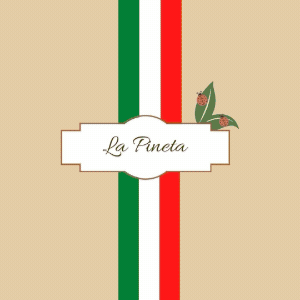di Redazione
MARINA DI GIOIOSA IONICA – Un vero tour culturale quello compiuto da Guido Pescosolido prima a Siderno, poi a Marina di Gioiosa, infine a Reggio Calabria.
L’occasione è stata offerta dalla presentazione del suo ultimo lavoro “LA QUESTIONE MERIDIONALE IN BREVE, CENTOCINQUANT’ANNI DI STORIA” (2017, Donzelli Editore): la “Questione” più discussa della nostra storia contemporanea, la “Questione” per antonomasia. Una sintesi essenziale delle sue più importanti tappe, dalle origine preunitarie fino ai giorni nostri.
Il professor Guido Pescosolido è Ordinario di Storia Moderna nell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha insegnato anche nelle Università di Messina, Napoli Federico II, RomaTre, Tuscia e Luiss. Tra le sue pubblicazioni sulla Storia economica, sociale e politica dell’Italia dal Secolo XVIII ai nostri giorni si ricordano: Stato e società 1870-1898, volume I della “Storia dell’Italia contemporanea” diretta da Renzo De Felice” (Edizioni Scientifiche Italiane); Agricoltura e Industria nell’Italia Unita (Laterza 2004); Unità Nazionale e sviluppo economico in Italia 1750 – 1913 (Edizioni Nuova Cultura 2014); Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia (Rubbettino, 2017).
Abbiamo incontrato il professor Pescosolido a margine dell’incontro avuto con gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “U. Zanotti Bianco” nella sala consiliare di Marina di Gioiosa Ionica.
1860: Quali erano ai blocchi di partenza del nuovo Regno d’Italia le condizioni economiche di Nord e Sud?
«Si può dire che entrambe le due macroaree della penisola avevano un’economia di tipo agricolo-commerciale. L’agricoltura era il ramo di attività largamente prevalente (quasi il 60% del pil – circa il 60-70% degli occupati). Le attività secondarie e quelle terziarie si dividevano in misura grosso modo equivalente il restante 40% del pil, sia al Nord che al Sud. Una differenza di Pil pro-capite tra Nord e Sud nel 1861 c’era, ma si aggirava intorno al 10%; oggi siamo oltre il 40%, con il pil per abitante del Mezzogiorno pari a circa il 55% di quello del Centro-Nord. Facciamo però attenzione: un divario così contenuto nel 1861 era dovuto al fatto che né il Nord, né il Sud avevano un apparato industriale paragonabile quantitativamente e qualitativamente a quello dei maggiori paesi europei industrializzati (Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Austria, Olanda). Se si considera che l’Italia intera nel 1861 produceva meno dell’1% della produzione di ferro e poco più dell’1% di quella di cotone dell’Inghilterra, si comprende facilmente che la superiorità del Nord-Italia rispetto al Sud, apparentemente accentuata sia in campo siderurgico che tessile, non aveva in realtà una consistenza significativa rispetto alla distanza schiacciante che sia il Nord quanto il Sud avrebbero dovuto colmare per dirsi economie autenticamente industrializzate come quella inglese o francese, belga, tedesca, austriaca. Nord e Sud d’Italia avevano cioè economie entrambe arretrate sulla strada dell’industrializzazione, e l’industrializzazione è stato il processo che ha consentito al genere umano di elevare le aspettative di vita medie alla nascita dai 30-40 anni dell’Ottocento agli oltre 80 anni di oggi e nel 1861 esso non poteva dirsi realmente avviato in nessuna parte della penisola, tant’è che l’abisso che si riscontrava in quell’anno tra l’Italia e l’Inghilterra si era creato quasi interamente nella prima metà dell’Ottocento. Le due economie, dunque, erano entrambe eminentemente agricole e per questo non registravano tra di loro grandi differenze nel prodotto pro-capite.
Grandi differenze non c’erano neppure nella marina mercantile. Quella del Regno delle Due Sicilie nel 1859 era la più consistente della penisola, tallonata da quella degli Stati Sardi, ma era inferiore alla somma di quest’ultima con la marina pontificia e toscana, senza considerare la veneta e la triestina. Inoltre la marineria napoletana, superiore nel tradizionale naviglio a vela e scafi in legno, era inferiore a quella sarda nel tonnellaggio dei piroscafi in ferro e a vapore.
Differenze rilevanti tra Nord e Sud si registravano invece nella struttura sociale delle campagne, con il Sud caratterizzato da una presenza del latifondo molto più accentuata di quella del Nord e quindi con una organizzazione produttiva relativamente più arretrata sulla via dell’affermazione dell’azienda capitalistica con impiego di manodopera salariata e alta intensità di capitale. Ma il divario maggiore si registrava nella consistenza quantitativa e qualitativa del sistema creditizio, nella inferiore dotazione di infrastrutture, stradali e soprattutto ferroviarie, nei livelli di alfabetizzazione. Il Regno delle due Sicilie arrivava all’Unità con due sole grandi banche e senza alcuna cassa di risparmio, con poco più di 100 Km di binari tutti intorno a Napoli contro 850 km del solo Piemonte (Abruzzi, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia ne erano del tutto prive). Il Sud continentale registrava quasi l’87% di analfabeti – la Sicilia l’89%, contro il 50-54% di Liguria, Lombardia, Piemonte. Infine il Sud era afflitto da una criminalità organizzata di tipo mafioso e camorristico che nel Nord era assente. Ed erano, queste, differenze prodotte tutte non dalla natura, ma dalle scelte di politica economica e civile della dinastia borbonica».
E’ vero quello che sostengono alcune correnti storiografiche che il Regno delle Due Sicilie fosse economicamente molto più ricco e solido del Nord?
«Credo proprio di no. Si può tutt’al più sostenere che il Nord non era molto più ricco e solido del Sud come alcuni leghisti e nostalgici asburgici affermano. Ma la ricchezza di un’economia non si misura solo, come fanno i neoborbonici, con la costruzione della prima ferrovia della penisola, quando poi il numero di km di ferrovie attive nel 1861 nell’Italia intera era di oltre 2.000 e il Sud ne aveva poco più di 100 e tutti concentrati in Campania, la rete stradale era in condizioni pessime, l’analfabetismo su livelli indegni di un paese civile, le aspettative di vita alla nascita di poco superiori ai 30 anni e più o meno sullo stesso livello del Centro-Nord. Alcuni stabilimenti industriali di pur ragguardevoli proporzioni, e comunque quanto a occupati e a produzione inferiori a quelli del Centro-Nord, non formavano un “sistema” industriale di tipo inglese. Il regno di Napoli non era certo la terza potenza industriale del mondo, come ha sostenuto Pino Aprile, e comunque era a distanza siderale da Inghilterra e Francia. l’Italia intera era ben lungi dall’esserlo. E’ vero che il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie era circa la metà di quello piemontese, ma era anche nettamente superiore a quello di tutte le altre regioni della penisola: nel 1861 Torino e Napoli, assieme, furono portatrici dell’80% del debito pubblico del nuovo Stato. Ciò significa che il Regno delle Due Sicilie quel che perse accollandosi parte del debito del Piemonte lo riguadagnò scaricando parte del proprio sulle spalle delle popolazioni centro-settentrionali non piemontesi entrate a far parte del Regno d’Italia. E soprattutto vale il fatto che il debito accumulato dal Piemonte negli anni Cinquanta era servito a costruire una delle migliori reti ferroviarie d’Europa in rapporto alla popolazione. Il debito pubblico del Regno di Napoli, il secondo della penisola, era stato accumulato soprattutto per le spese militari che poi non valsero a salvare la dinastia dal crollo del 1860».
Parliamo di Risorgimento: il Sud l’ha subito passivamente oppure ha avuto un suo ruolo?
«Il Mezzogiorno fu in prima linea nel movimento giacobino che a fine Settecento innalzò per la prima volta nella penisola la bandiera della libertà contro l’assolutismo politico e quella dell’Unità e indipendenza d’Italia contro la preponderanza austriaca. Dopo il Congresso di Vienna la prima rivoluzione carbonara scoppiò a Napoli nel 1820, chiedendo una costituzione che Ferdinando I concesse e poi ritirò dopo aver sollecitato e ottenuto l’intervento di un esercito austriaco che scese nel Sud e represse la rivoluzione liberale. Successivamente la migliore intellettualità meridionale partecipò attivamente al movimento costituzional-liberale che in tutta la penisola promosse una serie di sommosse e di iniziative culturali e scientifiche a favore della libera circolazione delle merci, degli uomini e delle idee, e nel 1848 fu parte attiva del movimento rivoluzionario che in tutta Italia ottenne le costituzioni in virtù delle quali sembrò aprirsi la strada della liberalizzazione istituzionale e politica e anche dell’istituzione di una Confederazione di Stati sull’onda del pensiero politico di Vincenzo Gioberti da un lato e di Carlo Cattaneo dall’altro. E tuttavia si sa come andò a finire. Ferdinando II, come Ferdinando I, già in maggio 1848 congelò e di fatto soppresse la costituzione appena concessa e represse duramente, nel sangue e nel carcere, il movimento liberale meridionale. Francesco De Sanctis e Silvio Spaventa, tanto per fare solo due nomi, marcirono nelle carceri borboniche e tutta una schiera di intellettuali meridionali prese la via dell’esilio, nella definitiva convinzione che qualunque discorso di modernizzazione politica, economica e sociale con i Borbone fosse impossibile e che solo il Regno di Sardegna, unico fra gli Stati della penisola a mantenere lo garantire Statuto concesso nel 1848, avrebbe potuto introdurre un regime liberale anche nel Mezzogiorno, guidando con successo un processo di unificazione dell’intera penisola. Uscito dal carcere, nel settembre 1853 lo stesso De Sanctis andò in esilio a Torino, dove trovò, fra gli altri meridionali, Camillo De Meis, i fratelli Agostino e Antonino Plutino, Mariano D’Ayala, Bertrando Spaventa, Giuseppe Massari, Antonio Scialoja, Paolo Emilio Imbriani, Pasquale Stanislao Mancini, Raffaele Conforti, Giuseppe Pisanelli, Pier Silvestro Leopardi, Antonio Ciccone, Giacomo Tofano, Salvatore Tommasi: quasi tutti ex deputati nel Parlamento napoletano del 1848 perseguitati dalla repressione borbonica, che assunsero un ruolo di primo piano negli eventi che portarono tra il 1859 e il 1861 alla liquidazione del Regno borbonico e alla nascita del Regno d’Italia. Senza la pressione degli esuli meridionali e del movimento nazionale del Sud, Garibaldi non sarebbe mai partito per la Sicilia. Sul piano della costruzione delle strutture istituzionali e amministrative del nuovo Stato unitario basterà pensare al ruolo cruciale svolto da Pasquale Stanislao Mancini non solo nel Sud, ma anche nel Nord. Insomma il Mezzogiorno non fu conquistato, ma diede il là decisivo alla nascita del Regno d’Italia con l’apporto dei suoi esuli, del suo ceto civile e di tutti coloro che combatterono nelle file dei volontari garibaldini fin sul Volturno per avere una vita politica, civile e materiale che i Borbone avevano loro negato».
Quando e perché comincia ad allargarsi il divario Nord-Sud?
«Premesso che il Mezzogiorno in 150 di vita dello Stato italiano ha fatto registrare in termini assoluti progressi considerevoli (il reddito pro-capite reale del Sud tra il 1861 e il 2010 si è moltiplicato per più di nove volte) e che se il divario dal 10% del 1861 è passato a oltre il 45% degli ultimi anni è stato dovuto al fatto che nel frattempo il reddito pro-capite del Centro-Nord si è moltiplicato di circa 15 volte; premesso inoltre che la società meridionale odierna, economicamente, socialmente e civilmente è radicalmente mutata rispetto a quella del 1861, è un fatto accertato che il divario Nord-Sud rimase stabile per oltre un ventennio dopo l’Unità, quando le due macroaree della penisola ebbero una crescita complessiva di reddito grosso modo equivalente. E’ vero che nel 1861 con l’adozione del libero scambio nel commercio con l’estero, le poche industrie meridionali, specie quelle siderurgiche e meccaniche, ma anche tessili, entrarono in crisi, con esiti in alcuni casi esiziali; ma è vero anche che l’agricoltura meridionale nel contempo si avvantaggiò della possibilità di collocare più facilmente all’estero i propri prodotti specializzati (vino, olio, seta, agrumi), i quali ebbero uno sviluppo vertiginoso, compensando in termini di reddito le perdite subite nelle attività manifatturiere. Il nuovo Stato innalzò il livello di tassazione rispetto a quello del regime borbonico, ma nel contempo dilatò la spesa pubblica e in particolare accrebbe lo sforzo in costruzioni ferroviarie riducendo significativamente il divario tra Nord e Sud esistente nel 1861 nella dotazione di binari.
Il divario cominciò invece a dilatarsi verso la metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, e più decisamente dopo il 1887, anno del passaggio della politica commerciale italiana dal liberismo al protezionismo, che causò una pesantissima ritorsione doganale della Francia (che era di gran lunga il maggior partner commerciale dell’Italia) sui prodotti agricoli e semilavorati italiani esportati oltralpe. La guerra commerciale con la Francia danneggiò l’economia meridionale molto più di quella settentrionale. Nel Mezzogiorno continentale e in Sicilia i danni furono enormi e colpirono proprio le colture specializzate (vino, olio, frutta) che dopo l’Unità si erano espanse ben più della cerealicoltura. Nel contempo si ebbe nel Nord una prima fase di industrializzazione, mentre il Sud consolidava la vocazione eminentemente agricola della sua economia. Fu allora che il divario Nord-Sud nel pil per abitante cominciò costantemente a crescere, giungendo nel primo decennio del Novecento a più che raddoppiarsi rispetto al 1861. Ciò avvenne non a causa di una recessione dell’economia agricola meridionale, che, superata la guerra commerciale con la Francia, aveva ripreso a crescere, bensì per la formazione nel Nord di una struttura industriale di livello europeo, grazie alla quale l’Italia iniziò ad accorciare le distanze rispetto ai paesi più industrializzati del Continente. Nel contempo l’economia del Sud restava marcatamente e persistentemente agricola, anche se ben più dinamica che in passato.
La prima guerra mondiale, richiedendo lo sviluppo un’industria bellica largamente concentrata nelle regioni settentrionali, accentuò ulteriormente il divario Nord-Sud mentre il Sud contribuiva alle spese di guerra e poi anche al peso finanziario dei dissesti seguiti alla riconversione dall’economia di guerra a quella di pace.
Durante il fascismo, i contenuti successi conseguiti in materia di bonifiche e la nascita di un consistente polo industriale intorno a Napoli, peraltro quasi del tutto distrutto dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale, furono in gran parte annullati ai fini del reddito per abitante dalla forte crescita della popolazione promossa dalla politica demografica del regime. All’inizio degli anni Cinquanta del Novecento il divario Nord-Sud nel pil per abitante toccò i suoi massimi storici (il reddito per abitante del Sud si attestava intorno al 55% di quello del Centro-Nord). La differenza tra un Nord industrializzato e un Sud in prevalenza agricolo era tutt’altro che attenuata. L’inferiorità meridionale era netta in materia di infrastrutture e di sviluppo civile in genere (il Sud aveva ancora il 24% di analfabeti, mentre nel Nord il fenomeno era pressoché scomparso).
Con gli anni Cinquanta ebbe però avvio la fase di più grande sviluppo economico che l’Italia unita abbia mai avuto e contestualmente anche il più determinato e finanziariamente imponente sforzo di dirottamento di risorse a favore del Mezzogiorno grazie alla riforma agraria e all’intervento straordinario attuato dalla Cassa per il Mezzogiorno. Allora anche nel Mezzogiorno nacquero numerosi nuclei industriali e l’agricoltura, pure in accelerata fase di ammodernamento, perse decisamente terreno di fronte all’avanzata dell’industria e soprattutto delle attività terziarie. Scomparve quasi completamente la società contadina meridionale esistente nel 1861. Quella meridionale divenne un’economia prevalentemente terziaria con consistente presenza anche di attività secondarie e un’agricoltura prevalentemente capitalistica».
Veniamo ai giorni più o meno nostri. Che ruolo ha esercitato nello sviluppo del Sud la Cassa per il Mezzogiorno?
«Un ruolo certamente positivo. Istituita nel 1950, specie negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso fu sicuramente lo strumento più efficace per la maggiore trasformazione economica e sociale del Mezzogiorno che mai si sia avuta nella storia dell’Italia unita, nonostante che le risorse a sua disposizione, benché senza precedenti, non superarono mai nel corso della sua storia la media dello 0,7% del Pil. Negli anni Ottanta la Cassa per il Mezzogiorno fu messa in liquidazione, sostituita dall’AgenSud, definitivamente chiusa nel 1992-3. Dopo di allora si ebbe un drastico crollo degli investimenti nel Mezzogiorno e il divario riprese ad allargarsi fino a ritornare nel XXI secolo più o meno al livello degli anni Cinquanta del Novecento».
C’è stato un momento in cui nel Secondo Dopoguerra il divario Nord- Sud si sia ridotto?
«Sì. Tra il 1962 e il 1973. Dal 1973 in poi il trend si invertì e il divario tornò a crescere. Progressivamente entrò in crisi la maggior parte delle attività industriali sorte nel precedente ventennio senza un corrispondente aumento compensativo dei flussi turistici e delle attività terziarie. Nel frattempo mafia, camorra e ‘ndrangheta, da fenomeno specificamente meridionale sono divenute fenomeno nazionale».
Quali le colpe, se ci sono, che possiamo attribuire alle classi dirigenti Meridionali (per tali intendendo politici, amministratori locali, partiti, sindacalisti) per questa inversione di tendenza che ha ricondotto il divario alle dimensioni quantitative degli anni Cinquanta del Novecento?
«Le colpe delle classi dirigenti meridionali rispetto a quanto accadde a partire dagli anni Settanta del Novecento sono state gravi, per una loro generale, anche se territorialmente differenziata, inadeguatezza a cogliere l’occasione offerta dalla congiuntura storica creatasi negli anni Sessanta per dare un colpo decisivo al divario territoriale; tuttavia va tenuto anche presente che le responsabilità delle classi dirigenti meridionali – senza che questo sia un’attenuante assolutoria – si collocarono in un contesto di responsabilità a livello nazionale che non furono meno gravi. Più precisamente: a fine anni Sessanta l’Italia aveva una condizione della finanza pubblica tanto florida quanto mai si era avuta in tutta la precedente storia unitaria e mai si è riavuta successivamente (si pensi che il rapporto debito pubblico/Pil era a fine anni Sessanta di poco superiore al 30% mentre oggi è a oltre il 130%); un apparato industriale tra i più forti del mondo; un regime di pressoché piena occupazione, un divario Nord-Sud in diminuzione grazie all’intervento straordinario. Sarebbe stato allora largamente possibile adottare a livello nazionale una rigorosa politica dei redditi e una programmazione volta prioritariamente a consolidare lo sviluppo industriale del Nord e del Sud e a ridurre in misura risolutiva il divario territoriale tra le due macroaree attraverso una oculata e sana politica di investimenti sulle strutture produttive, nelle infrastrutture, nella cultura, nella scuola, nella formazione professionale. Avvenne invece esattamente il contrario e a partire dal 1969 a livello nazionale si determinò quella svolta nelle relazioni tra movimento sindacale, mondo imprenditoriale e Stato che puntò a un aumento generalizzato dei salari e dei consumi assolutamente superiori agli aumenti di produttività, con, nel giro di pochi anni, una inevitabile conseguente inflazione a due cifre accentuata dalle crisi petrolifere. Nel contempo dilagò la degenerazione del sistema delle partecipazioni statali e fu avviata la costruzione di un welfare assolutamente al di sopra delle possibilità della finanza pubblica e dell’economia nazionale, che diede un contributo fortissimo a quella galoppata dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni che ha portato il rapporto debito pubblico/Pil ai pericolosi livelli odierni.
In questo contesto le regioni meridionali, da un lato entrarono in rotta di collisione con la Cassa per il Mezzogiorno, dall’altro assecondarono una politica di clientelismo e di sprechi nella loro spesa che assecondò a livello locale quell’occupazione dell’economia e della società da parte della partitocrazia che celebrava i propri fasti anche nel Nord, con l’aggravante che nel Sud c’era un divario cospicuo rispetto al Nord, che per essere colmato avrebbe avuto bisogno di tutt’altro che di spreco di risorse. Se a ciò si aggiunge il pessimo, o in diversi frangenti del tutto mancato, uso dei fondi europei per la coesione, il quadro delle responsabilità delle classi dirigenti meridionali si fanno veramente ingombranti».
Vede in questo momento motivi che la inducano ad essere ottimista?
«Si. Dopo la catastrofica contrazione del Pil nel 2008-14 (-12%), il Mezzogiorno ha ripreso a crescere e, per la prima volta dagli anni Settanta, a crescere più del Centro-Nord. E’ una performance dovuta ad una ripresa degli investimenti e si è registrata in tutti i settori dell’economia: agricoltura, turismo e servizi, e anche, ma ancora in misura contenuta, attività secondarie. Senza lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi, e posto che comunque bisognerà prima o poi eliminare tutti i fattori che dagli anni Settanta hanno compromesso un adeguato afflusso di investimenti (dai ritardi della giustizia civile e amministrativa al dilagare del crimine organizzato, dagli sperperi delle amministrazioni centrali e periferiche all’eccessivo carico fiscale, dal maggior costo rispetto all’estero dell’energia all’inferiorità infrastrutturale di un territorio nettamente più disagiato del Centro-Nord ) vedo alcune condizioni di vantaggio – o, se si vuole, di cessato o eliminabile svantaggio rispetto al Nord – sulle quali si può consolidare la ripresa e tornare a ridurre il divario. A parte il vantaggio che il Mezzogiorno può trarre dalle sue condizioni climatiche nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di colture agricole specializzate, mi limito a sottolineare che il ruolo del turismo potrebbe diventare veramente decisivo nel recupero di quote di reddito rispetto al Nord. Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento i grandi flussi turistici di massa nazionali e internazionali non esistevano o erano poca cosa. Oggi esistono e per il Mezzogiorno offrono prospettive di sviluppo superiori a quelle del Nord, perché nel Centro-Nord la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico ha raggiunto livelli ormai vicini al top, mentre nel Sud i margini di crescita sono molto superiori, se è vero che del totale nazionale degli attuali flussi turistici solo il 15% si rivolge a Sud di Roma. E’ questione di crederci e di avere classi dirigenti meridionali che, a differenza del passato, abbandonino i modelli culturali del vittimismo neoborbonico infondato e deresponsabilizzante e siano capaci: a) di tutelare e valorizzare al meglio il proprio patrimonio storico-artistico; b) di utilizzare i fondi strutturali europei del 2014-20 come hanno fatto in passato Spagna e Polonia; c) di proporsi allo Stato centrale come soggetto propulsivo al fine dell’annullamento in tempi rapidi dell’attuale gap esistente in materia di infrastrutture per poter mettere il Sud al centro dei grandi assi del commercio internazionale in transito nel Mediterraneo».